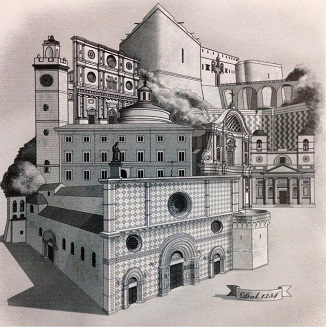Se solo il gioco del calcio fosse già esistito – così come noi lo conosciamo oggi -, nel volume dedicato all’isola di “Utopia” (1516), Tommaso Moro avrebbe potuto fantasticare anche sulle condizioni di uno stadio e di un tifo ideali. Nella sua puntuale descrizione di uno Stato privo di guerre ed intolleranza, estraneo a sperequazioni sociali ed economiche, dotato di istituzioni diverse e di abitudini migliori di quelle vigenti nella realtà, lo scrittore inglese avrebbe potuto favoleggiare su impianti sportivi e sostenitori degni dell’Eden.
Proviamo dunque ad immaginare un’ipotetica appendice alla celebre opera di Moro. Nell’isola di “Utopia” gli stadi sono tutti confortevoli e privi di barriere, il calcio è un gioco pulito, senza trucchi né grandi interessi, i calciatori rispettano le regole, si spendono completamente e non si risparmiano mai. Il pubblico, dal canto suo, non è da meno: sempre composto ed educato, il tifoso “utopiense” è attento al galateo, non emette neppure un colpo di tosse, figurarsi se può cedere alla logomachia – alla sordida guerra delle parole -, a cori disdicevoli o al tafferuglio. Nei templi del calcio del Luogo Ideale famiglie e bambini sciamano felicemente, la camomilla scorre a fiumi – solo di rado è alternata con qualche tisana -, lo zero a zero è il migliore dei risultati possibili e i tifosi della squadra avversaria sono sempre e solo amici, da accogliere con tiepidi e melliflui – come potrebbe essere diversamente? – caroselli di benvenuto.
Dietro a tanta melassa c’è però qualcosa che non va. A vederli da lontano i calciofili di “Utopia” sembrano delle mummie, afone e immobili. Il colore dominante è il grigio, lo spettacolo è spento, il sorriso stampato sul volto degli spettatori è velato di tristezza, il tifo – con i suoi colori e con il suo calore – è solo un ricordo.
Passato il primo entusiasmo, in uno stadio come quello di “Utopia”, dopo un po’ non andrebbe più nessuno. Le curve si svuoterebbero rapidamente. Quel calcio e quel tifo, monotoni, ovattati ed insipidi, risulterebbero peggiori e meno attraenti del calcio e del tifo praticati all’infuori del mondo ideale. Perché il calcio è passione, e il tifo – fin dai tempi dell’antica Roma, quando si parteggiava fanaticamente per i protagonisti delle gare del circo – è fede e contrapposizione: è una contesa ritualizzata, da esercitare con lealtà e senza violenza.
Anche le curve di oggi, come quelle immaginarie della malinconica “Utopia”, si stanno svuotando. Un po’ perché andare allo stadio è sempre meno un piacere – causa i tanti divieti e l’asfissiante burocrazia dei biglietti nominali e della tessera del tifoso – e sempre più un affanno. Un po’ perché la giustizia sportiva provvede a chiudere i settori tradizionalmente più caldi in ragione di una recente, bizzarra legge che punisce i cori contenenti una qualche “discriminazione territoriale”. Sia chiaro: ogni forma di razzismo e di violenza è inaccettabile. Ma la norma in questione – già applicata nei confronti di diverse curve, squalificate o “sospese” per cori anti-napoletani – è un non senso, una assurdità. Per più motivi. Perché non tiene conto della storia italiana, del peso, ancora fortissimo, dei municipalismi e delle antipatie di origine medievale. Perché è iniqua: interviene se si insultano i tifosi di un’altra città, non interviene se si insultano i tifosi della stessa città (come capita da sempre nelle stracittadine), o – fatto più grave – se si ingiuria un morto. Perché è la castrazione del tifo, di tutto il tifo, anche di quello votato al sano scherno: qualche anno fa, ad esempio, i sostenitori del Napoli realizzarono uno striscione contro i rivali veronesi ironizzando su Romeo e sulla fedeltà di Giulietta; allora quel messaggio velenoso strappò più di un sorriso, oggi comporterebbe la squalifica. Perché una legge ridondante – qual è quella contro un coro, pur becero – può dare origine, come già sta avvenendo, a significative forme di solidarietà tra le diverse curve, con un duplice rischio: che le società, destinatarie delle multe che accompagnano le squalifiche, vengano ricattate; che si arrivi ad una domenica di totale chiusura degli stadi.
La norma sulla “discriminazione territoriale” andrebbe dunque rivista. Anche per un’altra, e forse più importante, ragione. Perché, come ha scritto giorni fa Piero Ostellino in un pezzo di alto giornalismo, “un Paese nel quale il pensiero, le opinioni, le parole devono obbedire a una certa Ortodossia pubblica, imposta per legge, non è un Paese libero”. È un Paese – dotato di fragili libertà, incerto e smarrito – in cui si cerca di plasmare “un uomo artificiale”.
Venerdi 1 Novembre
[FONTE: Giornale dell’Umbria]
Sezione: dal mondo Ultras